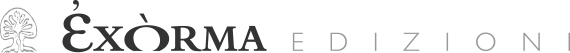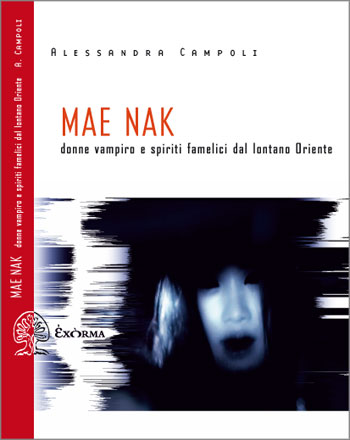L’esilio dei moscerini danzanti giapponesi
Un uomo, di professione traduttore, ha lasciato la sua terra d’origine, è andato lontano (in diversi lontani) e non è più tornato. Un esilio volontario, forse da sé stesso. Ritorni e ripartenze, dalle rive del mare di casa alle dune del Mare del Nord, nei luoghi anfibi dove la sera si radunano i gabbiani e i moscerini danzanti giapponesi.
I luoghi e le circostanze del passato e del presente si allacciano come in una treccia: i collegi, la valle ulivata dell’infanzia, le caserme e i reparti neuro dove colui che racconta ha vissuto «nei dieci anni di residenza nella notte»… Un’autobiografia, per frammenti e senza soggetto, che si presuppone vera proprio perché non c’è nessuna prova che lo sia. Il mare, le spiagge, l’orizzonte di sabbia, le acque ricorrono nel libro come un connettivo della nostalgia. Da un esilio all’altro, il luogo della presenza: «Dicono che gli esuli fanno bene due cose, una è camminare lungo le rive di un fiume, o di un mare, di un lago, di un canale. L’altra è non dormire la notte».
Vero protagonista del libro è la sua “voce”, che fa risuonare le parole nell’orecchio, ci trascina oltre l’affastellamento degli eventi di una vita. Magliani getta sassi nel pozzo, che febbrilmente ci troviamo, nostro malgrado, a benedire e rincorrere. Per poi ritrovarci anche noi, nel pozzo, senza sapere come ci siamo finiti. Come Dante che sviene sulle spiagge d’Acheronte, e si ritrova sulla porta dell’inferno.
Mia madre era una formidabile sterminatrice di mosche. In paese la morte delle mosche dipendeva dalle donne, se quel giorno si decideva di prendere il tè da scià Rafelina, a morire erano le mosche della cucina di scià Rafelina. Non importa se giravano nelle stanze o in sala, prima o poi si sarebbero posate da qualche parte in cucina e scià Rafelina e le sue amiche le avrebbero uccise.
Era un paese stradale, a tratti l’asfalto seguiva le anse ghiaiose del torrente, con vicoli eternamente all’ombra, e panchine di pietra su cui d’estate sedevano donne di ogni età. Poi a una cert’ora le braccianti tornavano agli uliveti e al fresco restavano solo le vecchie.
Vedevo tutte quelle donne salire in colonna come formiche, su per le mulattiere che dividevano gli orti e le vigne, e sparire dietro il costone, per poi rispuntare un attimo, fin quando la fronda azzurra non inghiottiva definitivamente scalinata e colonna.
Le vecchie raccontavano che anticamente esisteva anche un secondo paese, poi erano arrivate le formiche e il fiume nero aveva divorato le case.
***
Te ne ne stai piantato sulle terre cretose, i cieli solcati da incendi, e nel giro dei due o tre minuti in cui tordi, merli e pettirossi spengono o accendono vita e morte, se sei fortunato la vedi emergere dai vapori finali. È la nave dei sogni che bruciano. Quanto a me, come avrei fatto a crederci se da bambino mi avessero detto: sai, là sopra ci salirai più di trecento volte. Trecento volte! Ma dài, neanche un bambino se la berrebbe. Eppure c’è qualcosa che elude il numero delle mie presenze in Corsica, ed è che neanche così, neanche dopo esserci stato tutte quelle volte lì, posso dire di conoscerne i contorni. Di averne attraversato una strada, un orto, di essere entrato in una chiesa o in una trattoria corsa. Io dell’isola dei sogni che bruciavano e non restava nulla, ignoro tutto.