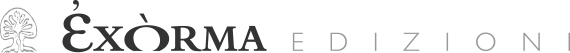“L’identità è porosa, gli esseri viventi sono assemblaggi di organismi, popolati da identità saprofite in una serie di sistemi dinamici che cooperano e si sfruttano a vicenda, finché il contesto e le risorse lo consentono. Sfruttamento e cooperazione, come il bene e il male, sono facce della stessa medaglia, che gira costantemente e vorticosamente su sé stessa, della quale siamo prigionieri sotto varie forme. È sempre stato così, l’errore, la visione parziale è di pensare le creature individui separati gli uni dagli altri”. In questo eloquente passaggio potrebbe racchiudersi una delle ragioni per le quali il pianeta Ork ha deciso fosse il caso di riportare all’attenzione dei lettori la scrittura di Tommaso Lisa nella forma della sua ultima creatura. “Insetti delle tenebre”, edito di recente da Exòrma, è anche un omaggio a quelle che, nella logica umana, appaiono contraddizioni del vivente e che sono più semplicemente la capacità della Natura di contenere tutto e il suo contrario in un gioco di equilibri che abbiamo saputo egregiamente alterare coerentemente all’imposizione di uno sguardo esclusivo, il nostro, che taglia ogni possibilità di affaccio al creato di dimensioni che ci scalzerebbero dal primato che abbiamo inflitto a questo pianeta. Crediamo di potere fare a meno dell’altro e non ci accorgiamo che l’intero sistema che regola il ciclo dei viventi non contempla la possibilità dell’atto dello scalzare e del conseguente scarto.
Chiaro ci si chieda quanto tutto questo nel processo creativo di Lisa possa rispondere a un atto di sincerità estrema: la composizione espressiva del testo, soprattutto in certi passaggi che coniugano la componente scientifica con un occhio esistenzialista, è di una tale finezza estetica che viene il dubbio che si stia celebrando la capacità umana di rendere la bellezza del mondo, incluso l’invisibile ai più, piuttosto che l’oggetto dello sguardo. Si risponde che, se anche fosse, mettere al servizio di creature di cui non sappiamo quasi nulla questo potenziale non può che essere un atto assolutamente meritorio e degno di menzione, nell’istante in cui, complici modalità di attrazione umane, ci conduce laddove mai metteremmo piede senza quella scrittura e senza subirne il fascino. Sarà anche vero che il desiderio di Lisa di scrivere è sorto per vivificare “la potenza tellurica” di quelle “occasioni di terribile grazia” di cui consta l’esistenza, che i suoi sono “sforzi futili rappresentati con perifrasi iperboliche e paradossali”, ma è altrettanto vero che l’esito di tutto questo travalica il suo esistere e, pur essendo la naturale scomposizione in singole ed estremamente efficaci istantanee dell’intimo battagliare tra sé e l’altro, senza alcun vincitore finale, non dimentica mai l’altro, sia in quanto protagonista quasi assoluto che in qualità di termine di confronto idoneo a restituire una dimensione dimenticata del suo e del nostro esistere. Questo accade perché, rispetto alla sua precedente pubblicazione ad opera del medesimo editore (“Memorie dal sottobosco”), l’autore pare essersi spostato oltre i suoi confini, pur nella resa che, in entrambi i testi, si compone di un raro livello di apporto scientifico, inglobando nella riflessione in merito alla sua personale condizione una speciale attenzione rivolta al genere umano, facendosi cantore di un’universale sofferenza che non ha soluzione.
Non è affatto casuale che il fautore di questo discorso a più atti abbia mutato il suo sguardo passando dal Diaperis boleti, cioè da quella speciale tipologia di coleotteri che si ciba di funghi e legno animando la vita che ci sfugge nei reconditi del bosco, ai coleotteri ipogei, “specie relitte originate dalle glaciazioni”, celebrando non esclusivamente la vita che è al di sotto della superficie terrestre che quotidianamente calpestiamo senza pensieri, ma anche la testimonianza di un tempo trapassato che ci appartiene nell’istante in cui un essere vivente naufragato “nel corso degli impetuosi stravolgimenti ecologici” e “rimasto incagliato negli interstizi più profondi” ci racconta di un’intima interconnessione temporale attraverso un’involontaria opera di eccellente mediazione. Risucchiando l’autore e il lettore in una dimensione atemporale favorita non solo dall’abisso in cui cade il pensiero nella retrocessione dello sguardo di milioni di anni, ma anche dal potenziale processo di identificazione con le piccole creature che, vivendo impossibilitati a distinguere la luce dal buio, dovranno percepire un tempo dilatato a dismisura, una sorte di “eterno presente”. Quantomeno in un’operazione in cui non cessiamo di sentire e conoscere la realtà con i nostri personali sensori e, dunque, fuori dall’altro o da questi piccolissimi altri. M chi sono più esattamente costoro? Sono quelli che resistono adattandosi o, più semplicemente, i fossili, istantanea di un momento che c’è stato e che ora esiste nella dimensione di una testimonianza di un passato (“Niente di definitivo si compie finché il fiume continua a scorrere, il mondo a danzare”), il punto di congiunzione che si esplica nei rimandi dell’osservazione delle forme che è già implicitamente una ricerca disperata di senso. Recita un passaggio: “Tutto si unisce nel nome dei coleotteri e del sottosuolo dove si coagula il senso, come nel collo di un imbuto, in una strozzatura”.
È il senso, unitamente alla forma che è classificazione, inquadramento, tentativo di comprensione, uno degli snodi del testo di Lisa. Non è, in questa logica, per nulla casuale il fatto che il discorso finisca per incanalarsi lungo vie linguistiche, rendendo l’opportunità offerta dalla parola la restituzione quasi materica del divenire, della trasformazione delle cose, quasi fosse essa, esattamente come il coleottero, un tentativo di mediare, tra passato e presente, tra chi guarda e chi è osservato, tra umani e animali. Un arresto del tempo dove portare luce tra quelli che appaiono “emblemi dell’innominabile, di ciò che resta impensato”. Come gli insetti si incagliano nelle fessure del terreno che, attraverso lo spazio delle grotte in cui l’uomo può avventurarsi, si rendono visibili e raccontabili ed esistenti in forme altre dal semplice essere al mondo, allo stesso modo la parola, nella forma dell’astrazione e del mito, celebra la ricerca di senso a quello che sarebbe altrimenti un incessante vagare, perché “ciò che ha un senso è, se non invisibile, per lo meno ben nascosto alla vista”. I coleotteri come parole e le parole come forma, dunque, e forma come possibilità di senso. Senso come scopo? L’evoluzione non ha un fine né una fine. Cercarli è un umano tentativo di trascendere il dato di realtà, ma il senso in un’accezione non riconducibile a queste declinazioni etimologiche è fuori, ci dice Lisa, da ogni operazione che sia in grado di giustificarlo. Eppure il senso, fuori dal margine finalistico, è l’anelito dell’intera composizione dello scrittore. Ciò che raccorda le istantanee di cui abbiamo detto. Esiste, allora, un modo per portare luce che non sia esclusivamente un “meccanicismo materialista”, che si spinga oltre il recinto della ricerca della causa per ogni effetto? Occorre andare verso il basso, il che non significa in automatico che la possibilità di senso debba necessariamente condurre in un posto situato nelle profondità della terra.
Può anche accadere che sotterraneo sia più semplicemente qualcosa di inespresso perché non sufficientemente conosciuto (“Senza dubbio v’è una bellezza nell’inventare cose che non hanno scopo, ma ancor maggiore nel rivelare altre dimensioni partendo da dati certi”). Esattamente come i coleotteri. Allora, in questo atto, che è un atto del guardare e poi del nominare, con l’intermediazione verbale o poetica, potrebbe esserci un senso, seppure con le derive di un apporto funzionalista alla discussione che rischia di annullare la bellezza vaticinante della perdita di Sé che certe culture, incluse quelle del sud del mondo, portano ontologicamente nella loro origine e nel loro sviluppo. In fondo, “la perdita di qualcosa è uno dei presupposti di ogni mutamento di forma” e, dunque, il migliore accesso a quella mutevolezza che la parola cerca di fermare. Chiusura del cerchio, parrebbe. Con qualche corollario necessario. Se scendere negli abissi è angosciante, il rischio è che l’individuo se ne discosti sempre di più. Esattamente come sta accadendo rispetto alla questione del collasso climatico. Vedere fa paura: così ci priviamo dell’opportunità di offrire un’alternativa al pianeta e di esplorare noi stessi, mettendo a tacere non solo il piano della conoscenza, primo essenziale step di ogni movimento sensato, ma anche quello più profondo della coscienza. Poiché non possiamo uscire da noi e, dunque, raccontare un reale oggettivo né tantomeno possiamo prescindere da esso che è il motore che attiva conoscenza e coscienza, succede che ci difendiamo negando l’esterno, mentre si accelera il moto di caduta del pianeta verso una fine senza ritorno, se non in assenza degli umani. Al piano di realtà così combinato rispetto alle nostre fatiche e ai nostri ritiri si aggiunge quello immaginativo troncato nella sua funzione da un eccesso di realtà da cui siamo invasi e che non lascia alcun margine al desiderio e al suo potenziale trasformativo impedendo l’interazione tra i due piani che è alla base di ogni possibile cambiamento. Sopprimendo la fantasia ci precludiamo l’accesso al senso di cui si è tanto parlato e non accediamo alla diversità. Questo perché in natura sopravvive il più adatto, quello che assurge a canone, mentre nella dimensione onirica c’è ancora spazio per il mostro che offre la forma alle nostre paure dandoci ingresso in quell’altrove ricco di senso più che di causa. Quell’altrove che abbiamo dimenticato, allontanato, misconosciuto e senza il quale la narrazione avrebbe un triste andamento evoluzionistico. Il senso, però, da solo non spiega la complessità del processo creativo dell’opera d’arte.
Esso si appella anche inevitabilmente alla memoria, sotto la cui lente passa l’oggetto della narrazione nel rispetto di una tempistica altra in confronto con lo scorrere quotidiano del presente, qualcosa che distorce ulteriormente ciò che ha subito già un processo selettivo nella scelta che abbiamo fatto di condurlo tra le nostre pagine. In nome di un sogno dietro al quale decidiamo di correre. Si badi bene: guardare sotto non equivale a non avere orizzonti. Manca il cielo, ma non la spinta verso ciò che non c’è: il desiderio, un senso. Persino alla luce del sole manca qualcosa a tal punto da indurre a scendere sotto. È un gioco di mancanze e di ricerca la vita degli uomini. Se, però, la luce arriva a bruciare la penombra dei sogni, succede che “la vita attiva fa a pezzi il corpo oscuro delle cose”, che la dimensione virtuale sostituisce l’esperienza e che l’immaginazione non possa più appellarsi a questa e finisca per spegnersi. Cosa che oggi non dovrebbe assolutamente accadere. In questo presente in cui, unitamente a misure scientifiche di contenimento del dramma climatico in cui siamo immersi fino al collo, immaginare aiuterebbe, in questa attesa che non può che essere di adattamento necessitato, a dare forma al nostro futuro prossimo venturo.
Mindy