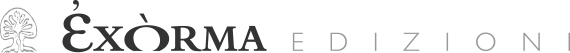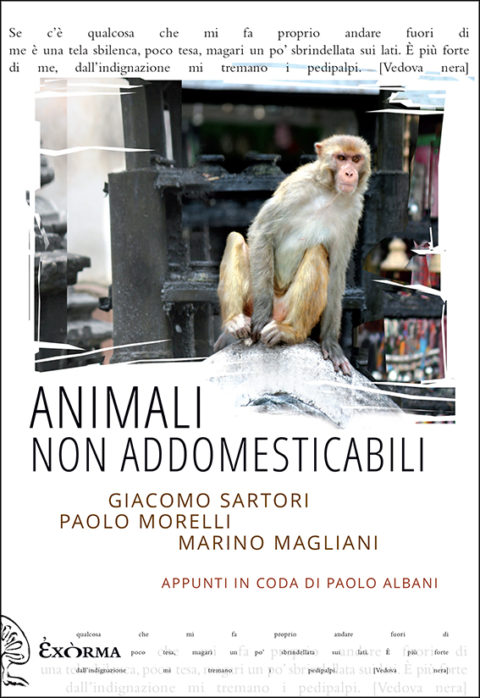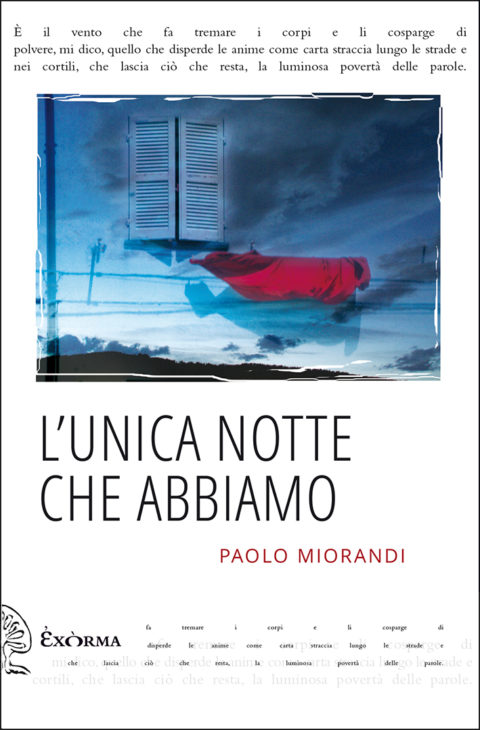Mascaró
Mascaró è una delle opere più vibranti della letteratura sudamericana del secolo scorso sulla libertà, la diversità, la forza sovversiva dell’arte. La scrittura di Haroldo Conti procede a briglia sciolta, abbraccia le voci, il paesaggio, odori e colori: le frasi danzano come in un tango argentino.
Tutto comincia una notte nella locanda di Arenales. L’orchestrina del paese si trascina suonando fino all’alba in attesa che il Mañana, una vecchia nave scalcinata, salpi per condurre Oreste verso un porto che forse non esiste. Insieme a lui si imbarcano lo stravagante Principe Patagón, il misterioso cavaliere Mascaró e altri passeggeri altrettanto fuori dal comune.
Sarà proprio il Principe, poeta, attore, mago e indovino certificato, alchimista, “praticamente imperatore”, a trascinare Oreste, e altri con lui, in un’impresa folle dando vita a un carosello di artisti girovaghi, guitti improvvisati e glorie decadute. Tutti abbandonano consapevolmente ogni legame con l’esistenza precedente per assumere una nuova identità. È una scelta consapevole per liberarsi da ogni vincolo e cercare la propria vera strada.
Ma, si sa, la libertà è loca, pazza e inafferrabile, misteriosa, e le autorità non possono tollerarla perché, ovunque arrivi questo manipolo di artisti, si accende nelle comunità un desiderio di ribellione e di riscatto.
Gli arresti e le torture che ne conseguono sembrano prefigurare in modo surreale la terribile sorte di Haroldo Conti, così come viene raccontata nella prefazione di Gabriel García Márquez.
È un’Argentina descritta con grande realismo e allo stesso tempo sospesa nella meraviglia, fatta di territori abbandonati, aridi deserti, miseri villaggi sperduti, dove Mascaró, alias Joselito Bembè, eroe e pistolero, figura emblematica della lotta per l’affrancamento, si muove, appare e scompare, vanamente inseguito dai rurales.
Il Principe entrò nella pensione dei signori López ed Esteve preceduto dal mastino eccentrico che dimenava la coda e annusava la zoccolatura di un lungo corridoio, riconoscendo le vestigia di antiche orine sovrapposte. Oreste e il Nuño seguirono il Principe, Bocca Storta rimase sul baroccio.
Per un po’, in una sala dai muri imbiancati a calce, attesero che i rumori provenienti da dietro un tramezzo si trasformassero nella persona incaricata di riceverli. Il pavimento di legno scricchiolava e quasi si incurvava a ogni passo. Una sporca lampadina da 25 watt pendeva da un soffitto di mattoni a vista poggiato su rozze travi di quebracho.
Nella sala c’erano tavolini con tovaglie di plastica, un banco, un vaso di fiori con calle e peonie di carta crepée, un orologio a pendolo, una sputacchiera, uno scaffale con qualche bottiglia e altri vasetti portafiori; sul tramezzo era appeso un diploma di appartenenza perpetua all’Opera Pia di Terrasanta, a nome di Maruca López Esteve, con a fianco la foto, vecchia assai, di un semicancellato signore con grossi baffi, un cappello schiacciato fin sulle sopracciglia, e occhi ritoccati a matita tanto da sembrare che gli uscissero dalla testa e, per poco che uno li guardava, davano il mal di mare. Ebbero tutto il tempo di osservare queste meschinerie da camera da letto esposte con semplicità, che per di più emanavano un forte odore di insetticida, e intanto continuavano i rumori dietro il tramezzo.
Attraverso l’unica finestra, nella parte più lontana della sala, Oreste guarda la lanterna del faro di Palmares, sospesa in alto nell’oscurità, come una navicella con luci tranquille e minuziose, uno sciame di bagliori che si agitano come piccoli ingranaggi arroventati.
Finalmente nel tramezzo si apre una porticina e invece dei signori López ed Esteve, o almeno uno dei due, entra scivolando di traverso un’imponente signora dall’aspetto maestoso che, nonostante ciò, sembra fluttuare nell’aria.
Il Principe spalanca gli occhi come per accogliere in un solo sguardo l’intera pienezza di quella donna fuori dal comune, confuso e sbigottito, si sente colpito al cuore. In quella signora c’è una graziosa incongruenza. Il suo corpo è una vera e propria mole, le membra olivastre sono disposte bene, aggraziate ma vigorose. Le gambe e le braccia, di netta rotondità, sono strade ondeggianti verso il segreto tumulto del ventre. I seni sono due angeli bene in carne che si agitano in sogno e segnano a dito proprio il Principe. Tutta questa abbondanza è fasciata da una semplice veste di cotone stampato con un colletto di pizzo. La dama ha un volto un po’ da bambina e una pelle burrosa con due fossette nelle gote, occhietti brillanti, capelli neri e lucidi, divisi al centro e raccolti sulla nuca in uno chignon.
La signora sorride e le fossette si accentuano.
– Benvenuti, signori – trilla.
I suoi occhi trascorrono sui presenti e vanno a soffermarsi sul Principe. Questi, con l’aria di riscuotersi da un incantesimo, si toglie il cappello, si batte il petto, prende la mano della dama, che si arrende come se fosse fatta di cotone, e la bacia con un certo impeto. La mano odora di sapone da bucato.
La signora ride, e pare un suono di campanelle.
Il Principe presenta i signori Oreste e Nuño, rispettivamente trasformista e attore tragico-lirico. Poi, abbassando lo sguardo, senza ridondanza ma anche senza falsa modestia, presenta sé stesso, il vero Principe Patagón:
– Recitatore, mago, indovino, scrittore e veggente… – decanta Oreste. Ma il Principe lo fa tacere con un gesto.
La signora congiunge allegramente le mani. In tutta la vita non ha mai visto un artista così da vicino. In genere, i pochi che vengono a Palmares, come Chucho Morales, alloggiano al Central Palace.
Il Principe fa presente che solo per motivi professionali frequenta quei luoghi, perché la sua natura è più incline ad altri, senza orpelli e senza chiasso. Per la stessa ragione prega la signora di non rendere nota la sua presenza in città: possibilmente, vorrebbe poi andarsene in modo anonimo. La prega inoltre di trasmettere i suoi saluti e queste stesse avvertenze ai signori López ed Esteve, dei quali ha avuto ottime referenze.
Il viso della signora diventa triste.
Il signor López, suo fratello, è morto cinque anni fa a causa di un “brutto granello”, a sua volta derivato dall’aggravarsi del “mal di freccia” che aveva contratto per l’abitudine di riposare steso all’ombra di un fico.
– Ma non ha messo una torta di cenere ai piedi dell’albero?
– L’avevo fatta io con le mie mani.
– Eh no, così non serve. Deve farla lui, il malato, e in più deve legare al tronco un filo rosso.
– E mio marito, il signor Esteve, – la donna rivolge un lacrimoso sguardo al barbuto di una fotografia che, di lassù, storce gli occhi – morì l’anno dopo di “acque bloccate”.
Il Principe scuote la testa rattristato, non soltanto per cortesia, ma perché si sente contorcere il pisello: le malattie di questo tipo lo impressionano.
– Eppure è morto senza soffrire – dice la signora. E lancia un’altra occhiata al barbuto.
Oreste osserva di sguincio la luce del faro fuori dalla finestra. Quando è diretta verso di loro, cioè verso la casa, se ne diramano anelli di fuoco, ma il centro è una fredda foglia dorata.